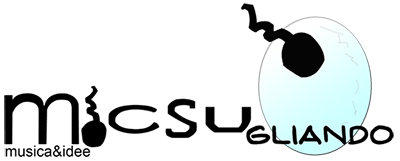4.
La Toscana, ormai annessa col Plebiscito, gli aveva regalato una pace inaspettata. Il calore delle persone lo rilassava, la generosità di Diego e degli altri amici del Caffè Michelangelo gli dava conforto per le sue vicende quotidiane, di cui raccontava poco o niente. Se ne usciva sempre la mattina presto e passeggiava a lungo nelle campagne, rientrando per lavorare su un quadro di interni; leggeva per alcune ore e poi cenava con altri artisti e studenti, finendo ogni giornata sui libri, oppure immerso in difficili problemi di scacchi.
Gli pareva che quella terra di monumenti, dove era più selvaggia, fosse capace di ascoltarlo in silenzio, di sopportare il suo umore cupo; dove era più viva, nelle città moderne, di fornirgli stimoli, idee e sogni. Era la sua casa: Giuseppe, in fondo, era uno che beveva acqua, pur di non gravare sull’oste.
Eppure, certi giorni, era sicuro che la vita gli sfuggisse, e così il senso della pittura. Vita e luce erano eternità – si confondevano – e creazione, insieme unite e inafferrabili.
5.
Un gran rabbia lo percorreva da cima a fondo; ripose i materiali a casaccio, piegò il quadro, lo guardò e poi vi rinunciò per sempre. Camminare – tornare indietro – gli avrebbe fatto bene, un passo dopo l’altro, e a gran falcate, accaldato, la testa che gli scoppiava, tirò un sospiro profondo e stabilì: cercare altrove.
Più a nord, si snodava un sentiero che tagliava tutta la boscaglia fino al mare. Ormai era giorno fatto, e la gente del posto si occupava dei propri affari. Giuseppe, come al solito, non vide nessuno in particolare, e continuò a scendere, imperterrito, fino al Botro della Piastraia. Lì, finalmente, si fermò.
Il ruscello scorreva nella terra desolata, strozzato da pietre e cespugli, che ne coprivano la foce: andava sinuoso e scompariva, poi riemergeva e si gettava nel mare. Sulla colline riconosceva la cascina dei Buoncristiani da una parte, e il villone Berti dall’altra. Avrebbe voluto dipingere subito – la luce cambiava -, invece non poteva far altro che mandare colori a memoria: bianco di zinco, crema, pesca, ambra e oro; rosso vermiglio, cadmio, sabbia e ruggine; e infine cachi, bistro, rame e terra di Siena.
Era davvero troppo stanco per ricominciare daccapo, e senza una tela adatta, ma l’occhio sinistro già brillava. Immobile su quella pietra, in verità correva già dietro al tempo, e cercava il taglio e la disposizione delle pietre, la trasparenza dell’acqua, l’inclinazione delle ombre e la morbidezza dei riflessi. Il quadro si formava per istinto mentre si chiedeva se non fosse vano qualunque sforzo; non riusciva a ignorare la sua velocità, imparava per contraddizioni, soffriva in silenzio, aveva guizzi di gioia.
Eppure, in qualche modo, la durezza di Castiglioncello temperava il suo spirito: Giuseppe dimenticava se stesso e non sentiva più niente, se non una vaga – struggente – nostalgia di Firenze.
6.
A quel punto aprii gli occhi. Caletta era invasa di vita, rimbombava di voci, e abbagliavano ancora il calore di luglio e le scaglie di luce sul mare.
Rimasi ancora un po’ sullo scoglio del porto, davanti al paese – bestia selvaggia prima – ora completamente addomesticato: la passeggiata era stata rivestita di marmo, il Botro della Piastraia seppellito nel cemento, e frotte di persone si accalcavano dentro bar e ristoranti, oppure negli stabilimenti balneari.
La Baia di Caletta – rimasta incompiuta – e la Marina a Castiglioncello di Giuseppe Abbati, così come le avevo viste al Castello Pasquini, certamente erano scomparse. Qualcos’altro, invece, era rimasto: un giorno d’inverno di molti anni fa, mio padre mi aveva portato su una scogliera e mi aveva detto che si chiamava la Luna. Le onde grosse entravano fra le fessure ed esplodevano, e io saltavo di pietra in pietra immaginando un allunaggio salmastro, e mari della tranquillità pieni di pesci.
Quel particolare mi avvicinava in qualche modo a Giuseppe, a ciò che aveva visto e sentito, e lo stesso faceva quell’uomo di Livorno, magro e abbronzato, che si metteva a dipingere a cavalcioni del muretto di Caletta. Veniva quasi tutti i giorni. Il sole picchiava, ma lui non si muoveva di un passo finché non terminava il lavoro, e, sotto l’ombra del cappello, aveva occhi brillanti, sempre fissi verso il Tirreno.
Al prossimo racconto!