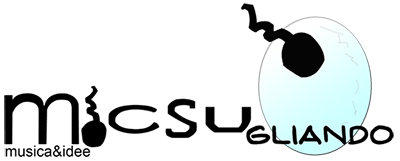Prima parte del racconto che avete ascoltato mercoledì 11 luglio su Punto Radio Cascina. Grazie a Chiara Moraglio che mi ha invitata in trasmissione e, poi, a partecipare al sito.
La Luna
Giuseppe aprì gli occhi per primo. Dalla finestra sentiva i rumori del mare – onde zaffiro si infrangevano sopra le scogliere, sotto le cicale – e riconosceva gli odori aspri della ginestra e del rosmarino. Luglio esplodeva – anche dentro di lui -: una strana emozione lo spingeva a non sprecare tempo, a rifiutare feste e discussioni di politica. Fremeva di passione. Gli importava solo la sua solitudine: buttarsi giù dal letto ogni volta prima del giorno, e ogni volta cercare.
Si alzò e si vestì come un animale selvatico; mise la benda al suo posto, prese la cassettina portastudi e una lampada, e uscì. Non una luce rischiarava la notte stellata, se non la sua.
Da Castiglioncello a Caletta c’era poco più di un chilometro verso sud, percorrendo la strada maestra in direzione di Vada e delle Colline Metallifere. Non incontrò anima viva mentre camminava. Si sentì, finalmente, libero di tacere, riconosciuto dalle bestie notturne, accompagnato dal vento fra i pini. Quella natura crudele e maestosa lo avvolgeva, ed era una sensazione mai provata prima, carica di desideri primordiali.
1.
La baia di Caletta era deserta – e al mistero orientale somigliava, forse -, dimenticata dai pescatori. Giuseppe osservava e non distingueva oggetti, solo variazioni tonali.
Cominciava appena ad albeggiare, alla sua sinistra, mentre il gozzo di ieri era ancora appoggiato al suo bastone, coperto da una tela logora. Il mare, in accordo, era calmo: si spezzettava, placido, sulle rocce e sulla piccola punta, chiamata la Luna.
Aspettò. Il paese gli si svegliava intorno, ma niente lo toccava se non la tavolozza e gli oli da diluire, e quella striscia di macchie di cui aveva decretato l’ultimo giorno di lavoro. Alla fine, non avrebbe avuto che un quadretto modesto, impossibile da vendere. Aspettò ancora. Una volta trovata la giusta posizione – il momento esatto -, tese la mano destra e caricò le ultime pennellate, come un fucile in una delle sue passate battaglie: colpire sempre, con precisione. Non era più frastornato dagli amici e dal chiasso, la sua energia convogliava tutta nel medesimo punto, proprio nel marrone seppia che gettava ombre sull’ocra, nel mare fiordaliso – così fragile – e nelle innumerevoli sfumature del cielo.
2.
Giuseppe aveva fama di essere un uomo serio e taciturno, che pensava e leggeva più degli altri, e che approfittava di qualunque occasione per farsi domande. Anche quel giorno, aggiustando il lavoro, cominciò a riflettere sulle questioni dell’arte: si dibatteva intorno alla Macchia, alla strada che la sua pittura aveva preso, e alla miseria di dover comunque eseguire studi d’interni – i chiostri di Santa Croce, San Miniato al Monte, le cripte – pur di guadagnare poche lire. Tirando le linee irregolari di Caletta, correndo dietro alla luce mutevole, aveva abbandonato le vecchie regole del colore e il trattato della pittura di Leonardo da Vinci, la correttezza di Raffaello e la grazia del Correggio. Perciò, ancora una volta, sedutosi a riposo su uno scoglio, e credendo finita l’opera, aveva giurato: mai un quadro liscio e freddo, senz’anima e senza rilievo; mai uno studio del vero basato sulla forma. Gridare, piuttosto, ai quattro venti, e ai professori che l’avrebbero preso a calci nel sedere, che la forma non esisteva affatto. Ogni panorama che la Toscana gli aveva offerto – le Porte Sante, San Gimignano, l’Arno alle Cascine – era semplice colore, e così emanava la sua bellezza. Tuttavia, per quanto perdesse la testa dietro a un bianco in ombra su di un cielo grigio, non riportava a casa che il solito quadretto, elogiato dagli amici e scartato dalle gallerie, che lo riduceva alla fame. Quella considerazione lo fece sorridere: invecchiando diventava lagnoso… Ogni tanto gli capitava persino di piangere dall’unico occhio rimastogli.
3.
Una volta, diversi anni fa, qualcuno gli aveva chiesto cos’era la vita, e lui, correndo da Napoli a Venezia per studiare, aveva gridato beffardo: un continuo girar di coglioni.
Da allora, erano accadute tante cose. Sua sorella Giulia era morta di tubercolosi e lui non aveva potuto essere avvertito che molti giorni dopo, con una missiva. Da sua madre, e dalle sorelle rimaste a Venezia, non poteva tornare: bandito dal Lombardo-Veneto, pena l’arresto. La benda sull’occhio destro gli ricordava sempre che il conto di Garibaldi e del patriottismo non si esauriva con un mancato funerale. Aveva combattuto coi Mille al Volturno, era stato ferito e trasportato all’ospedale di Napoli; poi, ad agosto dell’anno prima, era corso ad imbarcarsi per la disfatta dell’Aspromonte – salvo per miracolo grazie ai livornesi – ed era tornato svuotato. L’aveva fatta finita con l’unificazione: troppi intrighi, troppo disfattismo. Gli italiani, se esistevano, certamente dormivano.
Non aveva voluto né la medaglia al valore, né la pensione come reduce. E quel Garibaldi dei due mondi, con la sua camicia rossa – di sangue -, sul suo cavallo bianco, in mezzo alla mischia, non gli era sembrato, certe volte, neppure vero, neppure di carne come tutti quanti loro…